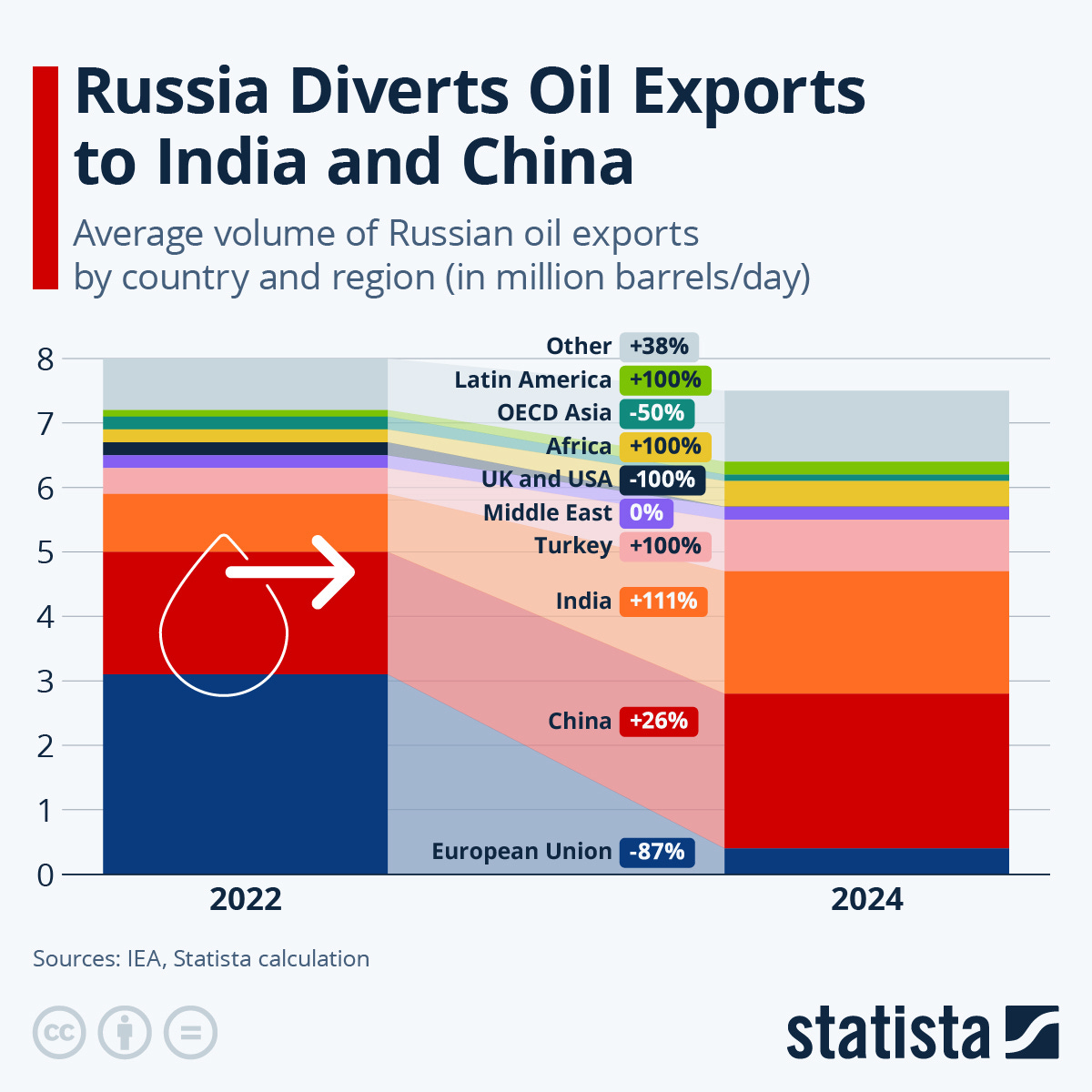A Pechino al via le "due sessioni"
Parola d'ordine "apertura": ridare fiducia alle aziende private e attirare investimenti esteri per promuovere lo sviluppo hi-tech
Benvenut* in Rassegna Cina.
Il Centro studi sulla Cina contemporanea (CSCC) ha organizzato per giovedì 6 marzo alla Camera dei Deputati il dibattito “Cina, Italia ed Europa nell’era Trump”. Le prenotazioni hanno già virtualmente riempito la sala “Giacomo Matteotti”: un segnale dell’interesse per le nostre iniziative e per il tema che affronteranno i relatori, tra i quali ci sarà il presidente del CSCC, Alberto Bradanini.
La storia si è messa a correre e nel nuovo mondo che sta prendendo forma sotto i nostri occhi la Cina è destinata a giocare un ruolo da protagonista. Che si tratti del commercio internazionale, delle “sue” istituzioni multilaterali, dello sviluppo hi-tech, non si può prescindere da Pechino. I tentativi di isolarla fanno parte di logiche del passato che hanno poco senso nell’attuale contesto internazionale, che non è quello, ingessato, della Guerra fredda, ma un mondo, di fatto, già multipolare.
Buongiorno da Shanghai da Michelangelo Cocco
Le due sessioni (liănghuì) si sono aperte questa mattina a Pechino con l’avvio della Conferenza politica consultiva del popolo cinese (Cpcpc) alla quale seguirà, domani, l’inaugurazione dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), con la lettura, da parte di Li Qiang, del rapporto sul lavoro del governo, che fornirà importanti indicazioni sulle prospettive di sviluppo socioeconomico della Cina. Con ogni probabilità il premier cinese indicherà per il 2025 (così come per i due anni precedenti) un obiettivo di crescita del prodotto interno lordo “intorno al 5 per cento”.
La prossima decina di giorni - durante i quali le liănghuì resteranno riunite - rappresentano uno dei rari momenti in cui è possibile “vedere all’opera” il sistema politico cinese: i 2.977 rappresentanti dell’Anp approveranno le leggi promosse dal governo, mentre i 2.169 delegati della Cpcpc, discuteranno con la leadership del partito comunista per conto delle diverse categorie sociali e professionali.
Le due priorità politiche della Cina - nel momento in cui la leadership disfunzionale di Donald Trump può permetterle di recuperare ulteriore terreno sugli Stati Uniti - sono: ridare fiducia al settore privato e recuperare quella degli investitori internazionali.
Sul primo fronte, durante la sessione annuale dell’Anp è attesa l’approvazione della Legge per la promozione dell’economia privata, che prevede che «nessuna entità può imporre tasse alle imprese private in violazione di leggi e regolamenti, imporre sanzioni senza fondamento giuridico o obbligare le imprese private a conferire beni». Servirà a proteggere il capitale privato dagli abusi delle autorità locali, le cui entrate dalla vendita di terreni sono state prosciugate dalla crisi del settore immobiliare.
È all’interno del settore privato che in Cina nascono e si sviluppano le startup - come DeepSeek (intelligenza artificiale) - fondamentali per la competizione tecnologica con le economie più avanzate.
The China School
Un viaggio straordinario alla scoperta dell'ascesa tecnologica della Cina
In Cina il settore privato contribuisce allo sviluppo socio-economico con:
il 50 per cento delle entrate fiscali;
il 60 per centro del prodotto interno lordo;
il 70 per cento dell’innovazione;
l’80 per cento dei posti di lavoro urbani.
La nuova norma fa seguito alle misure di politica monetaria e alle agevolazioni fiscali varate negli ultimi mesi per favorirne le operazioni.
Il 17 febbraio scorso Xi Jinping ha ricevuto nella Grande sala del popolo i magnati cinesi dell’hi-tech ai quali detto che «è il momento giusto affinché la maggior parte delle imprese e degli imprenditori privati dimostrino il proprio talento» e ha assicurato che «il governo proteggerà sinceramente, secondo la legge, i diritti delle imprese e degli imprenditori privati».
C’erano il presidente di BYD, Wang Chuanfu, il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, l’amministratore delegato di Xiaomi, Lei Jun, e quello di Tencent, Ma Huateng, il presidente di CATL, Zeng Yuqun, e il riabilitato Jack Ma, patron di Alibaba. Assenti invece (con conseguente crollo delle azioni in borsa) i top manager di Baidu e ByteDance.
Nello stesso tempo - alla vigilia delle due sessioni - le aziende di stato (Soe) hanno rivendicato il loro ruolo nell’ambito del “socialismo di mercato”. La Sasac, l’organismo che le rappresenta, ha dichiarato che «nel quadro delle nuove circostanze, compiti e obiettivi, le attività e le imprese statali di Pechino devono continuare a fungere da pietra angolare dello sviluppo economico e sociale di alta qualità del capitale».
La Sasac già nel 2022 ha istituito un’Agenzia per l’innovazione tecnologica, della quale fanno parte 58 delle 98 aziende di stato “centrali”, controllate direttamente dal governo di Pechino.
Altra questione importante, in un mondo in cui stanno riemergendo prepotentemente protezionismi e nazionalismi, è quella dell’attrazione in Cina di popolazioni e capitali stranieri, funzionale a due obiettivi principali:
mantenere il capitalismo globale legato alla Cina;
favorire lo sviluppo hi-tech della Cina.
Sul primo fronte il paese ha recentemente esteso a 30 giorni il soggiorno senza necessità di visto per 38 paesi (Italia inclusa).
Secondo le statistiche del ministero del commercio estero di Pechino (Mofcom), la crescita degli investimenti diretti esteri in Cina è scesa dal 4,5 per cento nel 2022 al -13,7 per cento nel 2023, per poi crollare ulteriormente del 27,1 per cento su base annua nel 2024, il calo più netto mai registrato con dati a partire dal 2008.
Per provare ad aumentare gli Ide in Cina, Mofcom e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) hanno annunciato parziali aperture pilota nei settori (finora completamente chiusi) delle telecomunicazioni, della sanità e dell’istruzione, secondo le linee guida riportate nel Piano d’azione del 2025 per stabilizzare gli investimenti stranieri.
«Il tentativo Usa di dividerci dalla Russia fallirà»,
il difficile equilibrismo della Cina sull’Ucraina
Attorno al tavolo allestito il 18 febbraio scorso dall’Arabia Saudita per avviare un dialogo Stati Uniti-Russia sull’Ucraina si è registrata l’assenza clamorosa dell’Unione Europea (esclusa, per ora, da Donald Trump e Vladimir Putin), ma anche della Cina, che pure il 24 febbraio 2023 aveva pubblicato la sua Posizione sulla soluzione politica della crisi ucraina e, il 15 aprile scorso, i Quattro princìpi di Xi Jinping per risolvere la crisi ucraina.
Xi è atteso a Mosca da Vladimir Putin il 9 maggio (sarà il loro quarantaquattresimo incontro da quando sono al potere), in occasione della Giornata della vittoria, alla quale potrebbe presenziare anche Trump. Il 24 febbraio scorso, nel terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina, Xi e Putin hanno avuto una conversazione telefonica, per coordinarsi sui colloqui russo-americani in corso.
Ci sarà poi un quarantacinquesimo faccia a faccia, perché Xi ha invitato Putin alla grande parata militare che si svolgerà a Pechino il 3 settembre, per l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.
Il 24 febbraio scorso, la Cina ha votato, assieme a Russia e Stati Uniti, in favore della risoluzione 2774, con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite - senza condannare l’invasione russa - «Implora una rapida fine del conflitto e sollecita inoltre una pace duratura tra l'Ucraina e la Federazione Russa», passata grazie all’astensione di Francia e Regno Unito.
Sempre lunedì 24 la Cina si è astenuta dalla risoluzione promossa dall’Ucraina e sostenuta dall’Unione europea “Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”, passata all’Assemblea generale con 93 «sì», 18 «no» e 65 astensioni.
A svelare il tentativo Usa di separare Cina e Russia è stato Marco Rubio. A “Breitbart News” il segretario di stato ha parlato di una Russia «sempre più dipendente dalla Cina, che non penso rappresenti un buon risultato» e ha aggiunto che «una Russia che diventasse un partner subordinato permanente della Cina rappresenterebbe un problema per gli Stati Uniti, con due potenze nucleari allineate contro».
Il portavoce del ministero degli esteri cinese, Lin Jian, ha replicato che «le strategie di sviluppo e le politiche estere di Cina e Russia (che condividono un confine lungo 4.300 chilometri, ndr) sono a lungo termine e le relazioni Cina-Russia andranno avanti con calma, indipendentemente dai cambiamenti globali. È del tutto inutile che gli Stati Uniti seminano discordia nelle relazioni sino-russe».
Ricercatori e analisti cinesi sottolineano che per la Russia non avrebbe senso “staccarsi dalla Cina per buttarsi tra le braccia degli Stati Uniti”, mentre quello che sta provando a fare Putin è riavvicinarsi a Washington - e, se possibile, all’Unione Europea - mantenendo nello stesso tempo ottime relazioni con Pechino, che ha sottolineato di vedere di buon occhio l’iniziativa di Trump che potrebbe favorire una cessazione delle ostilità in Ucraina.
Tuttavia Yu Jie - senior research fellow sulla Cina del programma Asia-Pacifico di Chatham House e tra gli speaker della nostra THE CHINA SCHOOL - in un’analisi pubblicata dal “Financial Times” ha scritto che Pechino «è preoccupata di un rapido rapprochement Usa-Russia», in quanto «legami più stretti tra i due paesi metterebbero a disagio Pechino, che investito tanto nelle sue relazioni bilaterali con la Russia, sia in termini di espansione commerciale che di capitale diplomatico». Pechino, secondo Yu, si terrà a una certa distanza da eventuali negoziati, anche per «la mancanza di fiducia delle élite europee», che non vuole alienarsi ulteriormente. Né proverà a sfruttare l’attuale frattura transatlantica, perché non vuole che Trump inasprisca di conseguenza il containment contro la Cina.
Tra l’altro - aggiungiamo noi - la Cina, che non ha riconosciuto l’annessione della Crimea nel 2014, difficilmente potrebbe partecipare a un negoziato che prevedesse quella di altri pezzi di territorio ucraino, se non contraddicendo radicalmente il rispetto, che considera “sacro”, del principio di integrità territoriale (Mongolia, Tibet e Xinjiang con le rispettive minoranze etniche costituiscono assieme oltre il 42 per cento del territorio della Cina).
Secondo Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), nella capitale saudita, oltre che della rimozione delle sanzioni contro Mosca e del ritorno in Russia delle aziende Usa a partire dal secondo trimestre di quest’anno, Rubio e Lavrov hanno esaminato progetti congiunti nell’Artico e in ambito energetico. Tuttavia, al di là degli affari, Russia e Stati Uniti hanno interessi geopolitici divergenti.
A cominciare dall’Artico, dove Trump ha rivendicato il controllo sulla Groenlandia, mentre Mosca ha iniziato a condurre war game con l’Esercito popolare di liberazione. Inoltre, tre anni di conflitto in Ucraina hanno fatto decollare l’interscambio Cina-Russia, in barba all’embargo decretato dal G7: da 147 miliardi di dollari (nel 2021) a 244,8 (l’anno scorso), evidenziando la complementarità (elettronica, automobili e prodotti chimici in cambio di idrocarburi) tra le rispettive economie, mentre Stati Uniti e Russia sui combustibili fossili sono concorrenti.
La Russia ha inaugurato da tempo una politica estera “rivolta verso Est”, in reazione ad anni di tensioni con l’Occidente e proiettata verso la de-dollarizzazione, mentre sperimenta con la Cina meccanismi per superare le sanzioni “unilaterali”.
Trump scommette tutto sulla forza (finanziaria e militare soprattutto) degli Stati Uniti, Xi e Putin sull’attrattiva del loro “multipolarismo” che promette protagonismo ai paesi del Sud globale. A Trump, che ha dichiarato che “gli piacerebbe” riportare la Russia nel G7, l’ambasciatore russo in Canada, Oleg Stepanov, ha risposto che Mosca «non ha alcun interesse a rivisitare istituzioni obsolete».
Durante i colloqui a margine del G20 della settimana scorsa a Johannesburg, Wang e Lavrov hanno concordato di aumentare la collaborazione nei nuovi organismi internazionali a trazione sino-russa - i Brics e la Shanghai Cooperation Organization - oltre che delle Nazioni Unite e del G20, facendo da contraltare al disprezzo ostentato da Trump per le piattaforme multilaterali.
Insomma se anche uno dei motivi per cui Trump vuole la pace in Ucraina è quello di concentrarsi contro il suo avversario strategico numero uno - la Cina - quest’ultima può contare su relazioni con la Russia che, proprio la guerra in Ucraina, ha irrobustito. Wang Yiwei, specialista in affari europei presso l’Università Renmin di Pechino, ha affermato che anni di sanzioni occidentali contro la Russia le hanno reso impossibile fidarsi dell’Occidente. «Dopo il conflitto Russia-Ucraina, l’industria, l’economia e l’energia russa sono state fortemente intrecciate con la Cina. Questo è strutturale e persino permanente. È difficile che ritorni verso l’Occidente», ha concluso.
I turisti cinesi snobbano Ue e Usa
Le tradizionali destinazioni europee e statunitensi sono sempre meno gettonate tra i viaggiatori cinesi, che invece si stanno orientando sempre di più per le loro vacanze e per affari verso paesi del Medio Oriente, del Sud-est asiatico e dell’America latina. È quanto risulta dai dati di Travelex, compagnia multinazionale specializzata nel cambio di valute.
Ebbene secondo Travelex, a partire dal 2019, euro, dollaro e sterlina britannica sono stati sempre meno richiesti dai viaggiatori della Repubblica popolare cinese. Cameron Hume, direttore di Travelex a Shanghai, ha spiegato che «nel complesso, gli Stati Uniti rappresentavano circa il 27 per cento del nostro volume nel 2019, ora circa il 17 per cento.
Gli scambi che coinvolgono sterline britanniche ed euro rappresentavano il 12 per cento del business di Travelex China nel 2019, ma sono scesi a circa il 7 per cento nel 2024.
A contribuire a questo cambiamento sono state anche le politiche del governo di Pechino, in particolare gli accordi di reciproca esenzione dal visto per i possessori di passaporto ordinario (per soggiorni generalmente di 15-30 giorni) sottoscritti con Malesia, Thailandia, Singapore, Emirati arabi uniti e una ventina di altri paesi.
La politica in Cina è in grado di orientare anche i flussi turistici. E così, ad esempio, Hume ha osservato che la crescente “vicinanza politica” tra la Cina e gli stati del Golfo ha portato a un “forte aumento” da parte di viaggiatori cinesi della domanda di valute di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman e Bahrein.
Al contrario la politica di esenzione del visto per 30 giorni estesa dalla Cina fino al 31 dicembre 2025 nei confronti di 38 paesi (tra cui l’Italia) è “unilaterale”, si tratta cioè di misure di apertura varate da Pechino che non sono state reciprocate dai paesi beneficiari e che non rientrano in accordi bilaterali di reciproca esenzione dal visto, in grado di favorire maggiormente il turismo e gli scambi tra popoli.
La stessa intensificazione delle relazioni “people to people” tra la Cina e i paesi del cosiddetto Sud globale si può osservare in senso opposto, nelle metropoli cinesi dove negli ultimi anni si è dimezzata la presenza di occidentali, mentre è cresciuta costantemente quella di turisti, uomini d’affari e lavoratori mediorientali, asiatici e africani.
Tornando ai viaggi in uscita, in particolare la richiesta di valute dell’America latina (Brasile, Messico, Perù) da parte di cinesi è triplicata per effetto sia dei viaggi d’affari che di turismo.
Travelex prevede che il mercato dei viaggi in uscita dalla Cina continuerà a crescere nel resto del decennio, con i turisti in uscita che passeranno da 150 milioni nel 2019 a 200 milioni entro il 2030. «Prevediamo che lo yuan al di fuori della Cina rappresenterà circa il 10 per cento del nostro volume di vendita al dettaglio globale. Adesso è probabilmente al 4 per cento, ma sta ancora aumentando e ovviamente è strettamente collegato ai viaggi cinesi in uscita», ha concluso Hume.
Cosa sto leggendo
From Trade Wars to Trade Wins: How Trump Can Redefine U.S.-China Economic Relations Zngyuan Zoe Liu
Rebuilding trust in China’s food safety system Lei Liu, Meilin Tang
Digging Deep Into China’s Zimbabwean Tobacco Business Chen Xiang